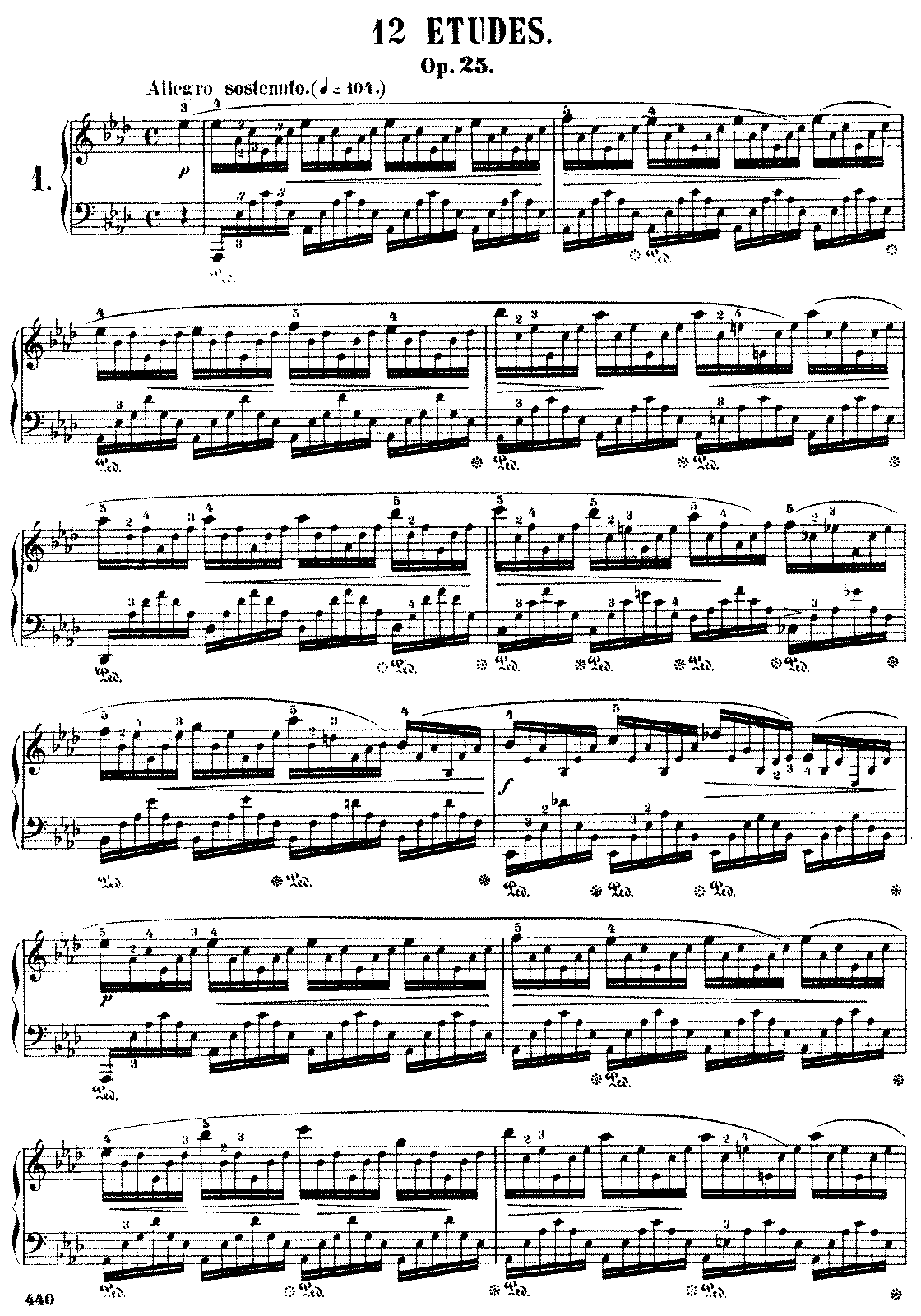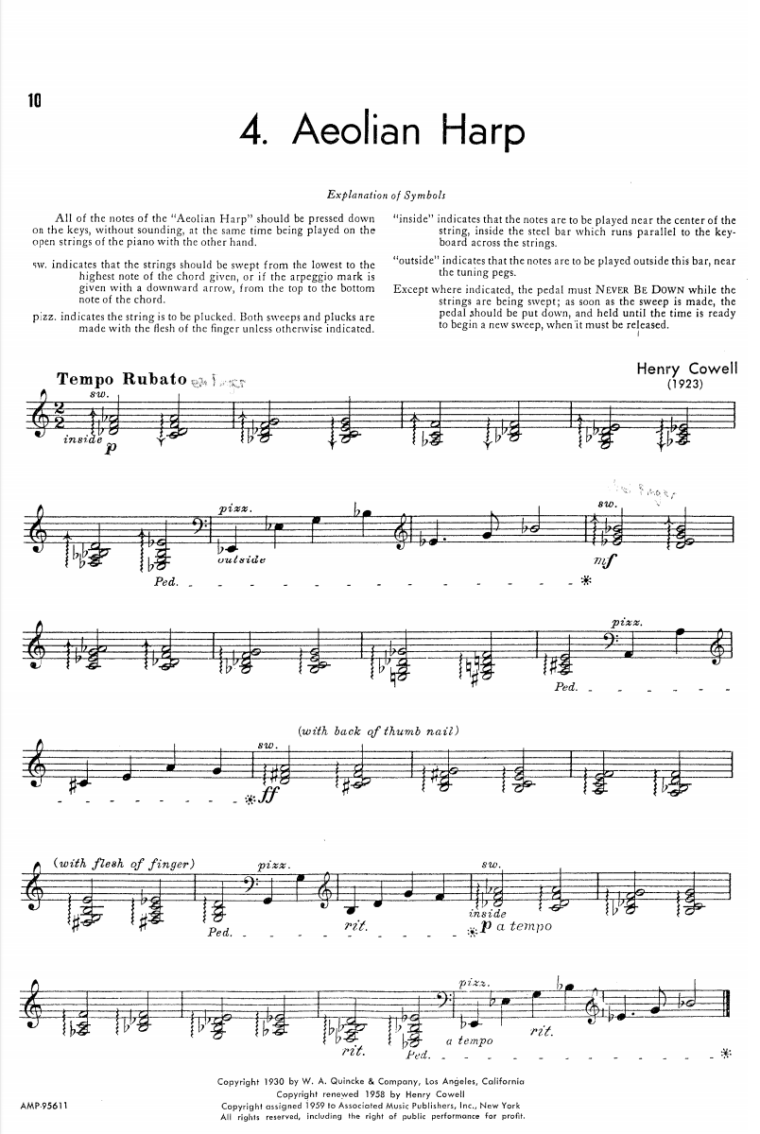Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, cantata BWV 12 su testo di Salomo Franck (forse) e Samuel Rodigast (n. 7); eseguita per la prima volta a Weimar il 22 aprile 1714. Paul Esswood, contraltista; Kurt Equiluz, tenore; Max van Egmond, basso; Tölzer Knabenchor, dir. Gerhard Schmidt-Gaden; King’s College Choir Cambridge, dir. David Willcocks; Leonhardt-Consort, dir. Gustav Leonhardt.
- Sinfonia: Adagio assai
- Coro: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen [2:20]
- Récitativo: Wir müssen durch viel Trübsal [8:21]
- Aria: Kreuz und Krone sind verbunden [9:19]
- Aria: Ich folge Christo nach [15:45]
- Aria: Sei getreu, alle Pein [18:33]
- Corale: Was Gott tut, das ist wohlgetan [22:50]
Il basso ostinato del coro (n. 2) della cantata bachiana è costituito da una successione cromatica discendente di quattro note (passus duriusculus : secondo le convenzioni della retorica musicale, i cromatismi ascendenti o discendenti esprimono dolore). Su questo basso ostinato Franz Liszt compose un Präludium per pianoforte (R 23, 1859; dedicato a Anton Grigor’evič Rubinštejn) che qui possiamo ascoltare nell’interpretazione di Vladimir Horowitz:
In seguito, Liszt scrisse una serie di Variationen über den Basso continuo von J. S. Bachs Kantate «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» (R 24, anch’esse dedicate a A. G. Rubinštejn), composte sotto l’impressione della morte di Blandine Ollivier, la figlia che il musicista ungherese aveva avuto da Catherine-Adelaide Méran e che era defunta a Saint-Tropez l’11 settembre 1862. L’esecuzione che vi propongo è di Artur Aksenov:
Liszt rielaborò poi le variazioni in una versione organistica (R 382, dedicata a Alexander Wilhelm Gottschalg, organista e Kantor di Tiefurt), qui eseguita da Thibaut Duret all’organo Michel-Merklin-Kuyhn di Saint Louis de la Guillotière, a Lione: