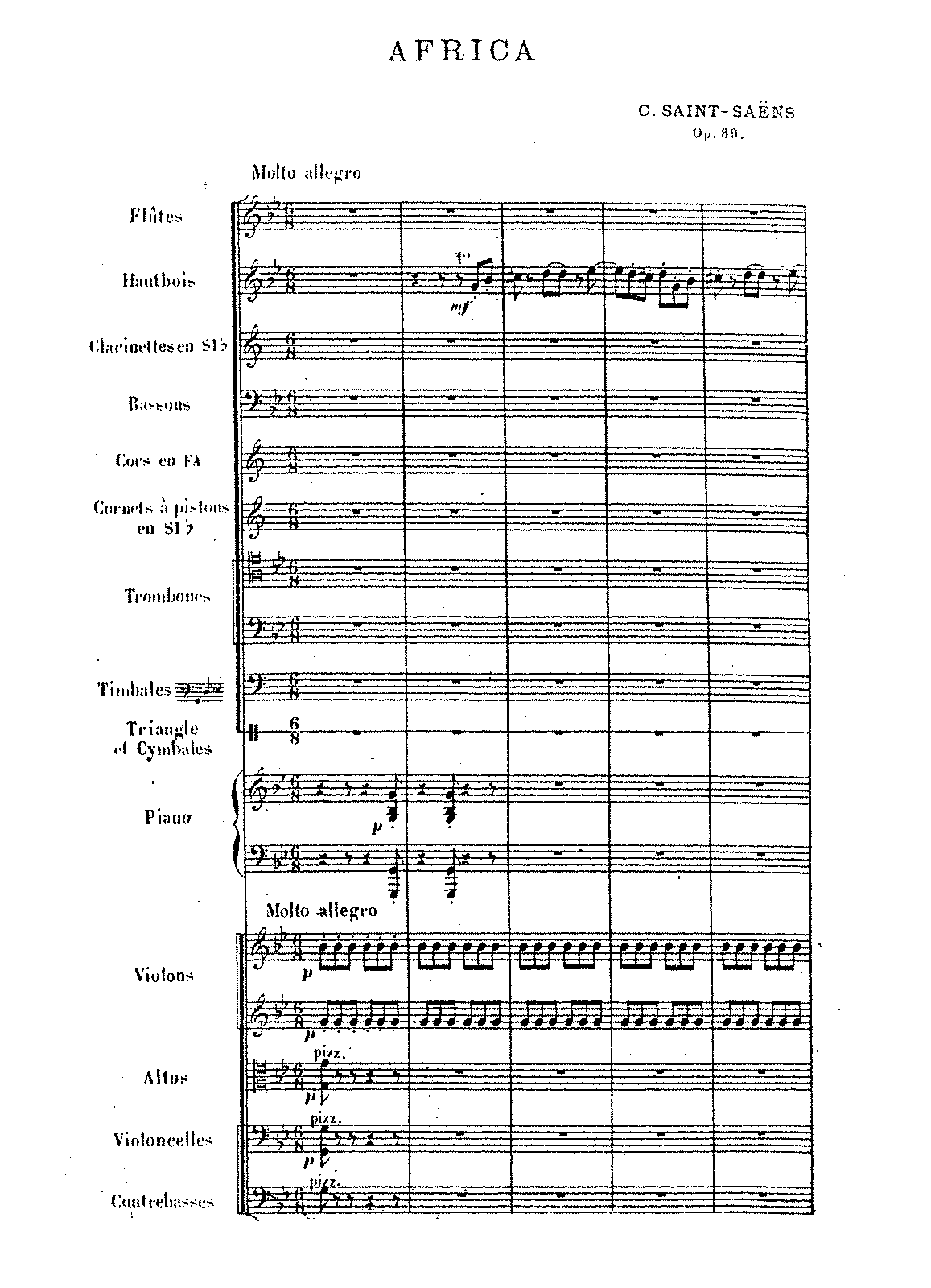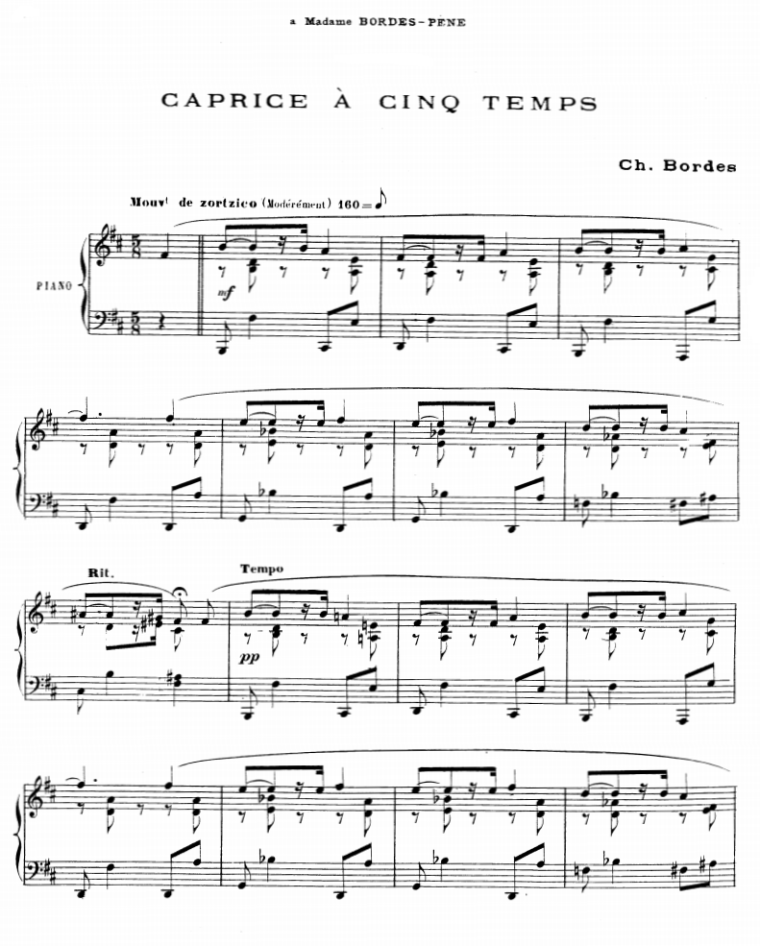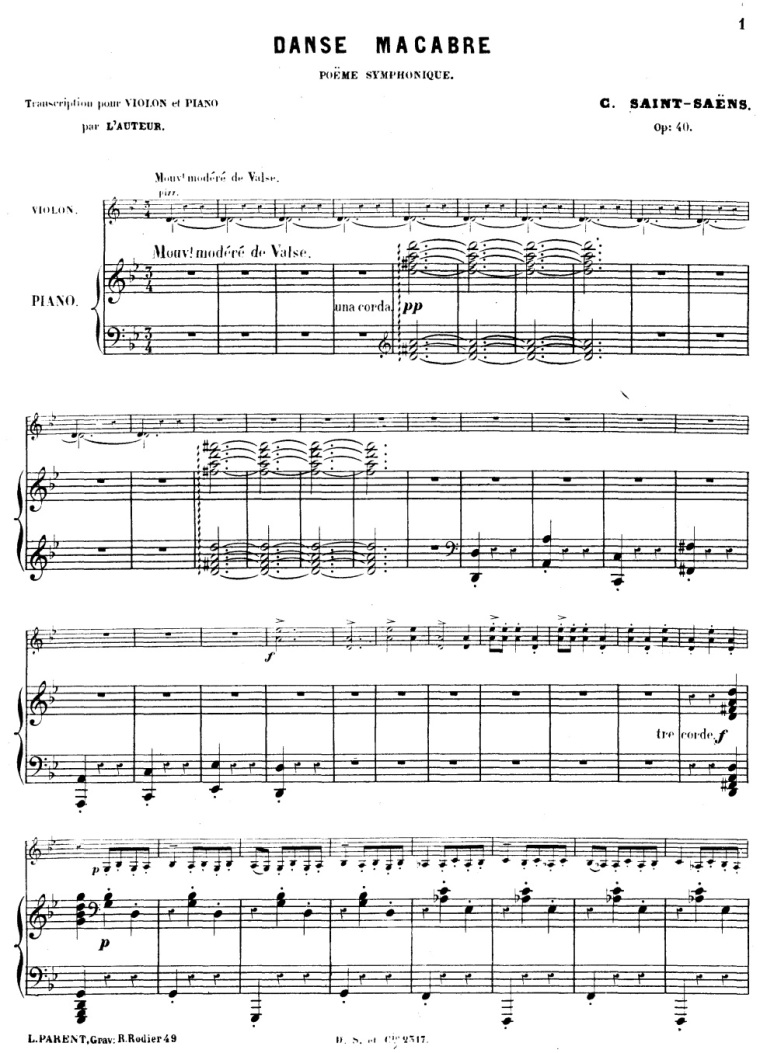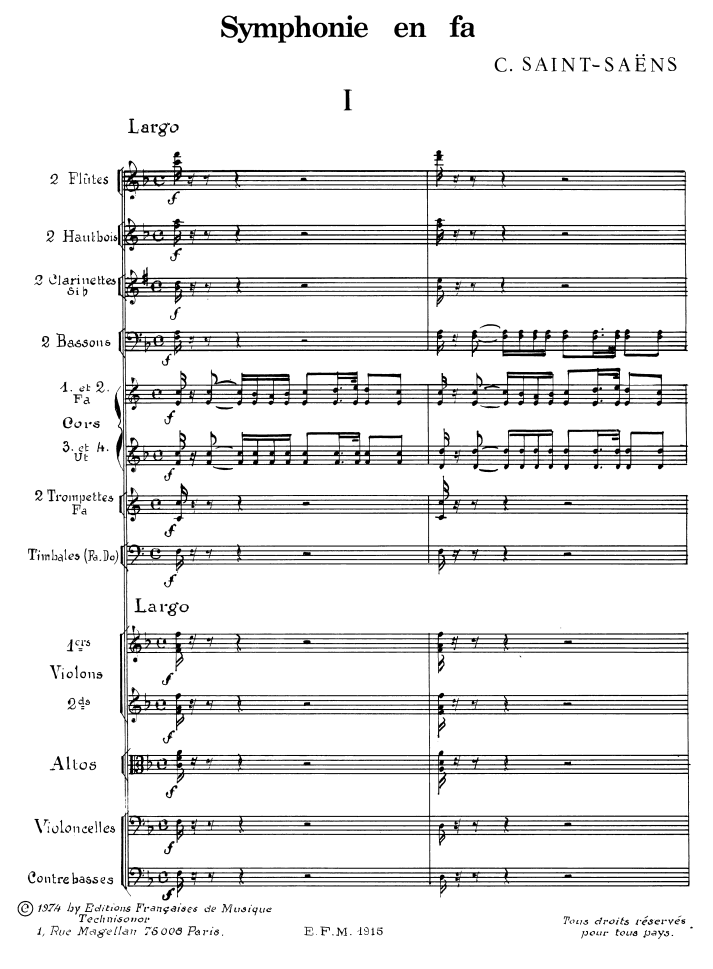Camille Saint-Saëns (9 ottobre 1835 - 1921): Introduction et Rondo capriccioso in la minore per violino e orchestra op. 28 (1863). Itzhak Perlman, violino; New York Philharmonic orchestra, dir. Zubin Mehta.
Lo stesso brano nella trascrizione per due pianoforti di Claude Debussy. Jean-François Heisser e Georges Pludermacher.
 Camille Saint-Saëns
Camille Saint-Saëns
 Claude Debussy
Claude Debussy
L’approfondimento
di Pierfrancesco Di Vanni
L’Introduction et Rondo capriccioso in la minore per violino e orchestra è un’opera virtuosistica e profondamente espressiva che mette in risalto sia la bellezza melodica che la brillantezza tecnica del violino solista.
Originariamente, fu concepita come movimento finale di un’opera più ampia, ma poi divenne un pezzo autonomo, eseguito in “prima” assoluta a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées il 4 aprile 1867. Primo esecutore e dedicatario del brano fu il violinista spagnolo Pablo de Sarasate, a quel tempo ancora agli inizi della sua carriera. Fu proprio a lui che il compositore si ispirò nella composizione del pezzo, inserendo al suo interno delle evidenti allusioni stilistiche spagnoleggianti.
Saint-Saëns aveva conosciuto il famoso compositore spagnolo già nel 1859, rimanendo subito stregato dal suo talento. In quell’anno, Sarasate gli aveva commissionato un concerto per violino, presentandolo al pubblico durante la prima dell’Introduction. Successivamente, il compositore francese dedicò al suo amico anche il Concerto n. 3 per violino e orchestra, il quale divenne uno dei più celebri pezzi del repertorio violinistico.
Il pezzo si articola in due sezioni principali: un’introduzione lenta e malinconica, seguita da un rondò vivace e capriccioso.
L’introduzione si apre con l’indicazione di tempo Andante malinconico e, fin dalle prime note, si percepisce un’atmosfera di profonda introspezione e tristezza.
Il violino solista entra quasi subito dopo il breve accordo d’orchestra, stabilendo la tonalità di impianto. La melodia è frammentata, con note lunghe e sospese, seguite da brevi, struggenti frasi discendenti. L’accompagnamento orchestrale, appena percettibile, è fornito dagli archi con accordi tenuti, creando un sottofondo etereo che non compete mai con la voce del solista.
La melodia si sviluppa con maggiore fluidità, introducendo passaggi con doppie corde che aggiungono densità e risonanza al suono del violino. L’orchestra rimane un tappeto sonoro, tessendo armonie che sostengono la linea melodica principale. Pur mantenendo il carattere malinconico e il tempo lento, iniziano ad apparire figure più complesse e arpeggiate: questi non sono ancora sfoggi di virtuosismo, ma piuttosto ornamentazioni espressive che arricchiscono il discorso musicale.
La musica raggiunge un punto culminante emotivo e la melodia si innalza a registri più acuti, con un aumento dinamico che passa dal piano al mezzoforte e oltre. I passaggi si fanno più densi e appassionati, caratterizzandosi per la presenza di rapide scale e arpeggi ascendenti e discendenti. L’orchestra risponde con maggiore partecipazione, fornendo un supporto armonico più robusto.
Dopo il climax, la musica si placa gradualmente. Il violino rallenta, scendendo a figure più sommesse e frammentate. Questo segmento funge da transizione, preparando l’ascoltatore per il contrasto netto che seguirà. La melodia si dissolve quasi in un sospiro, creando un’aspettativa risolutiva per l’ingresso del Rondò.
Quest’ultimo è caratterizzato dall’indicazione Allegro ma non troppo e segna un cambiamento radicale di atmosfera, con un’esplosione di energia e vivacità, spesso associata a ritmi spagnoleggianti.
Con un’entrata improvvisa e brillante, il violino attacca il tema principale, un motivo ritmico, incisivo e altamente virtuosistico in la minore. Il carattere “capriccioso” del titolo è immediatamente evidente e l’orchestra fornisce un accompagnamento staccato e ritmicamente propulsivo, supportando il violino senza mai offuscarlo. La dinamica è vivace, quasi ininterrottamente forte.
Segue un momento di leggero contrasto, sebbene l’energia generale rimanga alta. La melodia si fa più cantabile e si alternano scale rapide e frasi più ampie ed espressive, spesso con doppie corde e arpeggi veloci. La tonalità tende a spostarsi verso il maggiore, donando un carattere più brillante rispetto al tema principale.
Questo riappare, ancora più brillante e virtuosistico, seguito da un secondo episodio di marcato contrasto. Il tempo rallenta e la tonalità si sposta definitivamente verso il maggiore. La melodia è lirica e sentimentalmente romantica, quasi una serenata spagnola. L’orchestra crea un sottofondo caldo e armonioso.
Un breve passaggio ripristina l’energia e la tensione, con figure ascendenti e discendenti che conducono al ritorno del tema principale, il quale si ripresenta con rinnovato vigore, ulteriormente elaborato e più complesso. Segue il terzo episodio, una sezione di estremo virtuosismo che porta il solista al limite delle sue capacità. Si assiste a un moto perpetuo di scale rapidissime, arpeggi spezzati, salti di corda e picchettati volanti. Questa sezione è un vero tour de force per il violinista e l’orchestra accompagna con brevi e potenti staccati che sottolineano il ritmo frenetico.
Il tema principale del Rondò fa la sua ultima apparizione, più esaltante e trionfale che mai. Il ritmo accelera ulteriormente e la dinamica aumenta, portando la musica a una conclusione grandiosa. Seguono brevi e intense sezioni virtuosistiche, concludendo con una coda che rappresenta la celebrazione finale del virtuosismo e dell’energia. Il violino solista e l’orchestra si uniscono in una serie di passaggi brillanti, scale ascendenti e accordi potenti. Perlman conclude con una serie di note acute e fortissimo, terminando il pezzo con una sferzante e definitiva cadenza finale.
Nel complesso, la composizione non è solo un brano virtuosistico, ma anche un’opera di grande profondità emotiva e ricchezza melodica. La sua struttura contrastante, con un’apertura quasi meditativa che lascia il posto a una danza spagnola travolgente, lo rende un pezzo affascinante e un pilastro del repertorio violinistico.