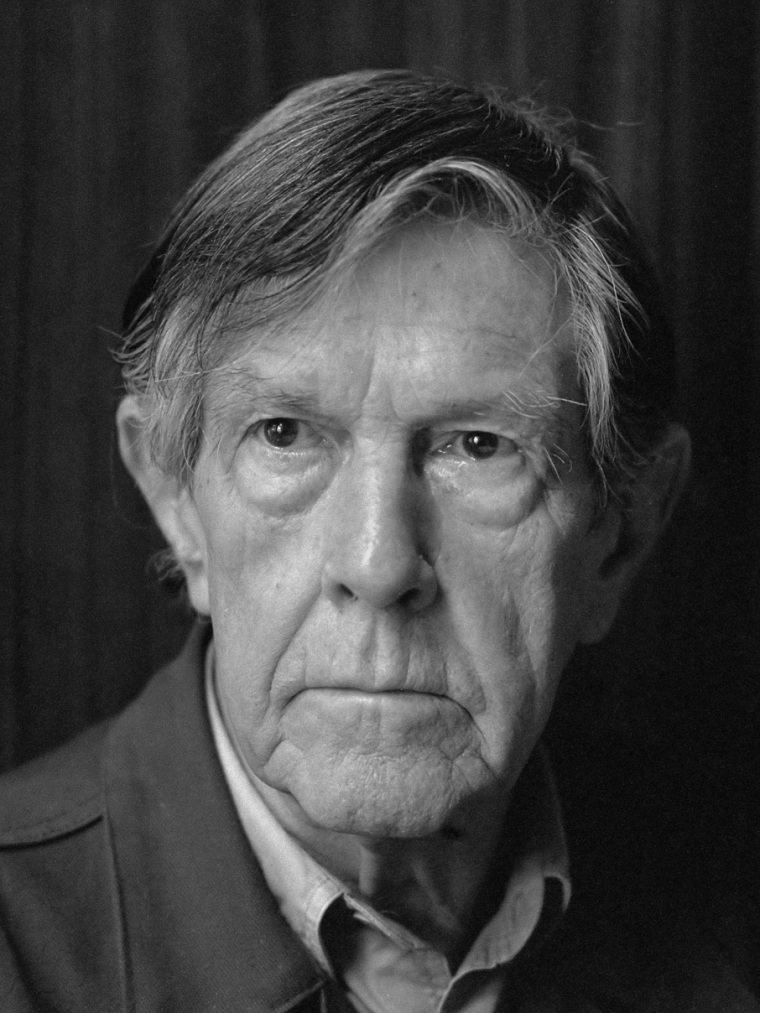Robert Schumann (1810 - 29 luglio 1856): Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38, Frühlingssymphonie (1841). Wiener Philharmoniker, dir. Leonard Bernstein.
- Andante un poco maestoso – Allegro molto vivace
- Larghetto [11:37]
- Scherzo: Molto vivace [19:30]
- Allegro animato e grazioso [25:35]
L’approfondimento
di Pierfrancesco Di Vanni
La Sinfonia n. 1 rappresenta un punto di svolta fondamentale nella carriera di Robert Schumann. Composta nel 1841, l’anno successivo al suo agognato matrimonio con Clara Wieck, quest’opera segna il suo primo grande successo nel campo della musica sinfonica, un genere che fino ad allora aveva affrontato con esitazione. Incoraggiato proprio da Clara, che vedeva nella scrittura orchestrale il campo d’azione ideale per l’immaginazione del marito, Schumann riversò in questa sinfonia un’energia creativa travolgente, completando lo schizzo in soli quattro giorni. Il sottotitolo assegnato alla composizione non è casuale: benché Schumann abbia poi eliminato i titoli programmatici che in un primo tempo aveva dato a ciascun movimento, la sua intenzione era chiara, come rivelato in una sua lettera: evocare il risveglio della natura e le passioni che la primavera suscita nell’animo umano.
La sinfonia ha inizio con una fanfara di trombe e corni, un «richiamo al risveglio» che, secondo le parole di Schumann, dovrebbe suonare «come se venisse dall’alto». L’orchestra subito risponde con un suono nobile e solenne, per poi lasciare spazio a un’atmosfera più cupa e misteriosa, dove archi e legni introducono un senso di attesa, come la natura che attende di germogliare sotto la coltre invernale. Un improvviso accelerando scatena l’Allegro: l’orchestra esplode in un tema gioioso e ritmico, che incarna «tutto ciò che riguarda la primavera che prende vita». I violini si scambiano agili frasi melodiche, mentre i legni dialogano con leggerezza, quasi a rappresentare «una farfalla che volteggia nell’aria». Il secondo tema è più cantabile e lirico, affidato ai clarinetti e ai violini, e offre un momentaneo respiro prima che l’energia ritmica riprenda il sopravvento. Lo sviluppo è un turbinio di frammenti tematici, in cui Schumann dimostra la propria maestria contrappuntistica: particolarmente suggestivo è il dialogo tra i corni e i legni, e l’uso innovativo dei timpani, il cui rullare aggiunge una tensione drammatica. La ripresa riporta la gioia iniziale, culminando in una coda trionfale dove l’intera orchestra celebra la piena esplosione della primavera.
Il secondo movimento – originariamente intitolato Sera – è un momento di pura poesia lirica: gli archi intonano una melodia tenera e sognante, quasi una romanza senza parole. L’atmosfera è intima e contemplativa e un dialogo delicato si sviluppa tra gli archi, in particolare tra violini e violoncelli e i legni. La conclusione del movimento è magistrale: anziché chiudere nella tonalità di mi bemolle maggiore, una solenne chiamata dei tromboni modula verso il re maggiore, creando un ponte sonoro che si collega direttamente, senza alcuna pausa, al movimento successivo.
Attaccandosi senza soluzione di continuità al Larghetto, lo Scherzo irrompe con un tema vigoroso e quasi rustico, in re minore: il ritmo è martellante e l’energia palpabile, evocando l’idea delle «allegre compagnie». La struttura dello scherzo è insolita, con due trii: il primo porta un cambio di umore e tonalità, con una sezione più leggera e giocosa, un valzer stilizzato in cui i legni e gli archi dialogano con vivacità, mentre il secondo trio (in si bemolle maggiore) introduce un’atmosfera più intima e riflessiva, quasi un ricordo del tema dell’introduzione del primo movimento, con i corni in evidenza. Lo Scherzo ritorna per una breve ripresa prima di una coda accelerata che conduce a una conclusione energica e affermativa in re maggiore.
Il movimento conclusivo – «Primavera in pieno rigoglio» – si apre con una scala ascendente piena di grazia e slancio, suonata dall’intera orchestra che introduce subito un’atmosfera di gioia festosa. Il primo tema è leggero e danzante, pieno di eleganza (“grazioso”), con i violini che eseguono con agilità le veloci figurazioni. Un momento di particolare bellezza è l’assolo del flauto che introduce una cadenza virtuosistica prima che il tema principale ritorni con ancora più forza. L’elemento più caratteristico del finale è la fanfara dei corni, un richiamo gioioso che attraversa l’intero movimento, conferendogli un carattere eroico e celebrativo. Lo sviluppo è un crescendo continuo di energia, con l’orchestra che si lancia in un vortice sonoro inarrestabile. La coda accelera ulteriormente, spingendo la sinfonia verso una conclusione esuberante e trionfale, suggellata da un potente accordo finale dell’intera orchestra.


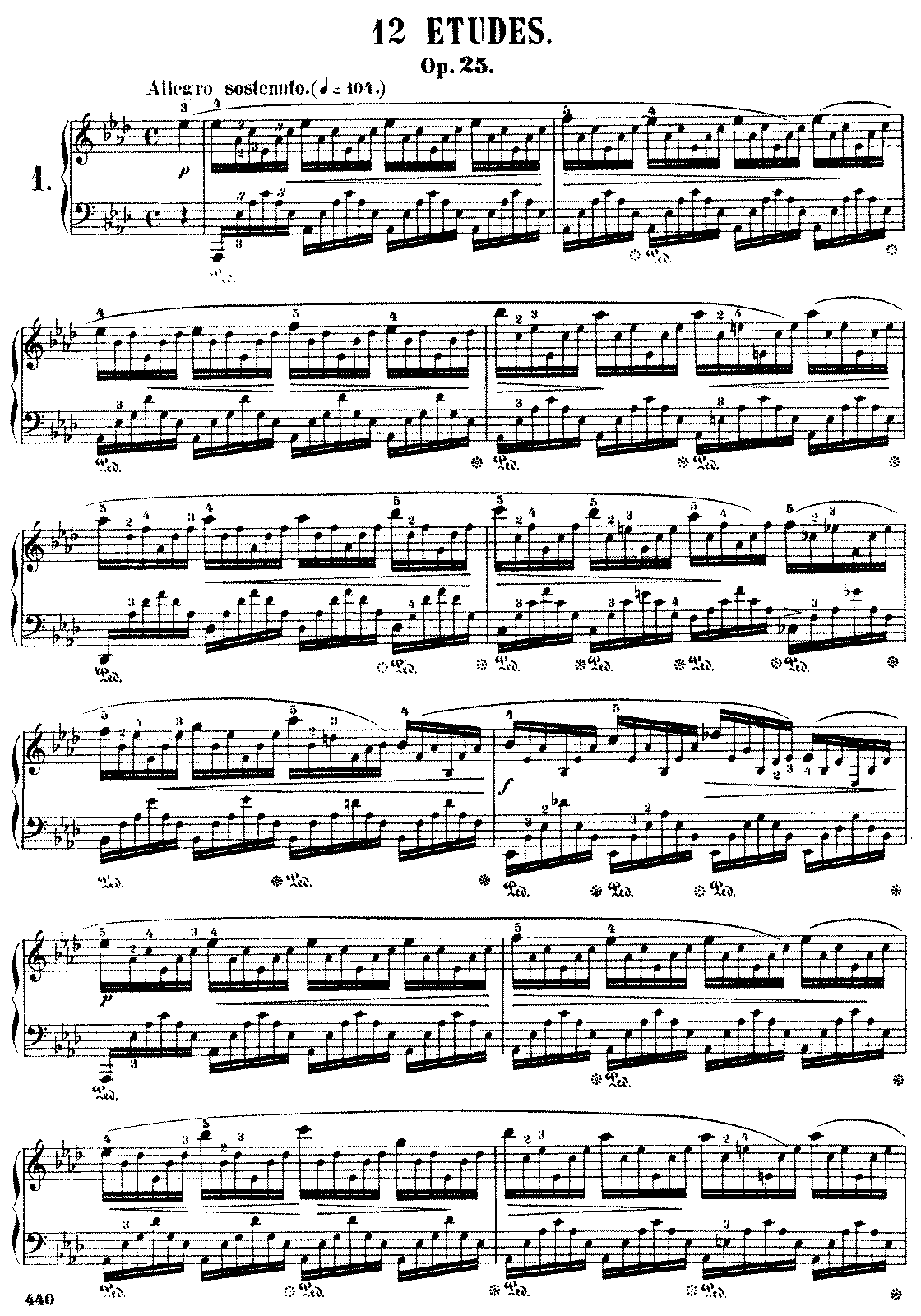
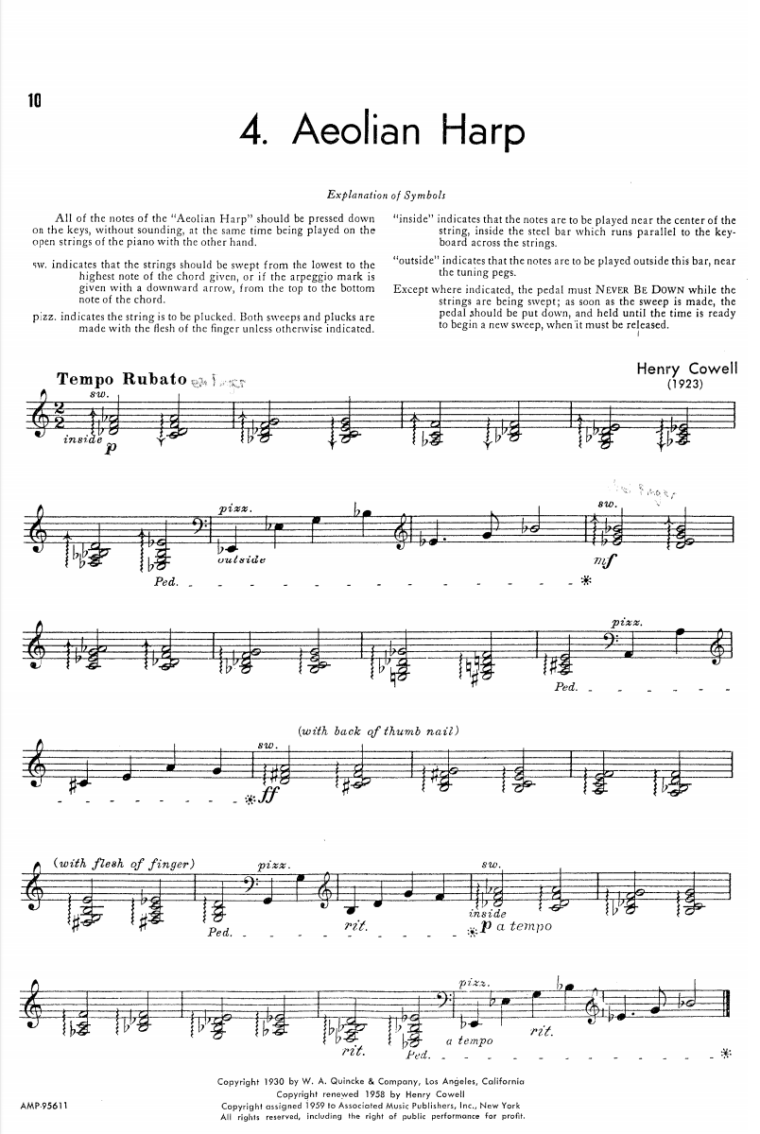






 Albert Lortzing (23 ottobre 1801 - 1851): Konzertstück in mi maggiore per corno e orchestra. Peter Damm, corno; Staatskapelle Dresden, dir. Siegfried Kurz.
Albert Lortzing (23 ottobre 1801 - 1851): Konzertstück in mi maggiore per corno e orchestra. Peter Damm, corno; Staatskapelle Dresden, dir. Siegfried Kurz.  Robert Schumann (1810 - 1956): Konzertstück per 4 corni e orchestra op. 86 (1849). Roger Montgomery, Gavin Edwards, Susan Dent e Robert Maskell, corni; Orchestre révolutionnaire et romantique, dir. John Eliot Gardiner.
Robert Schumann (1810 - 1956): Konzertstück per 4 corni e orchestra op. 86 (1849). Roger Montgomery, Gavin Edwards, Susan Dent e Robert Maskell, corni; Orchestre révolutionnaire et romantique, dir. John Eliot Gardiner.