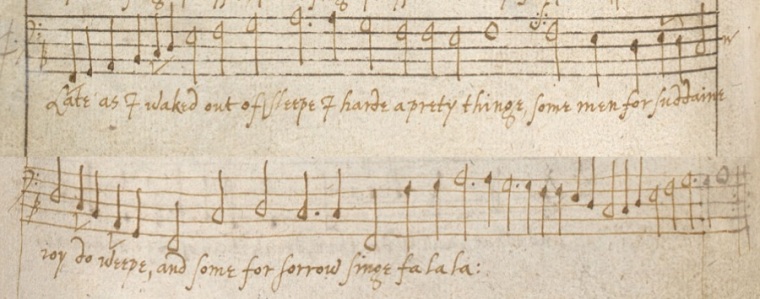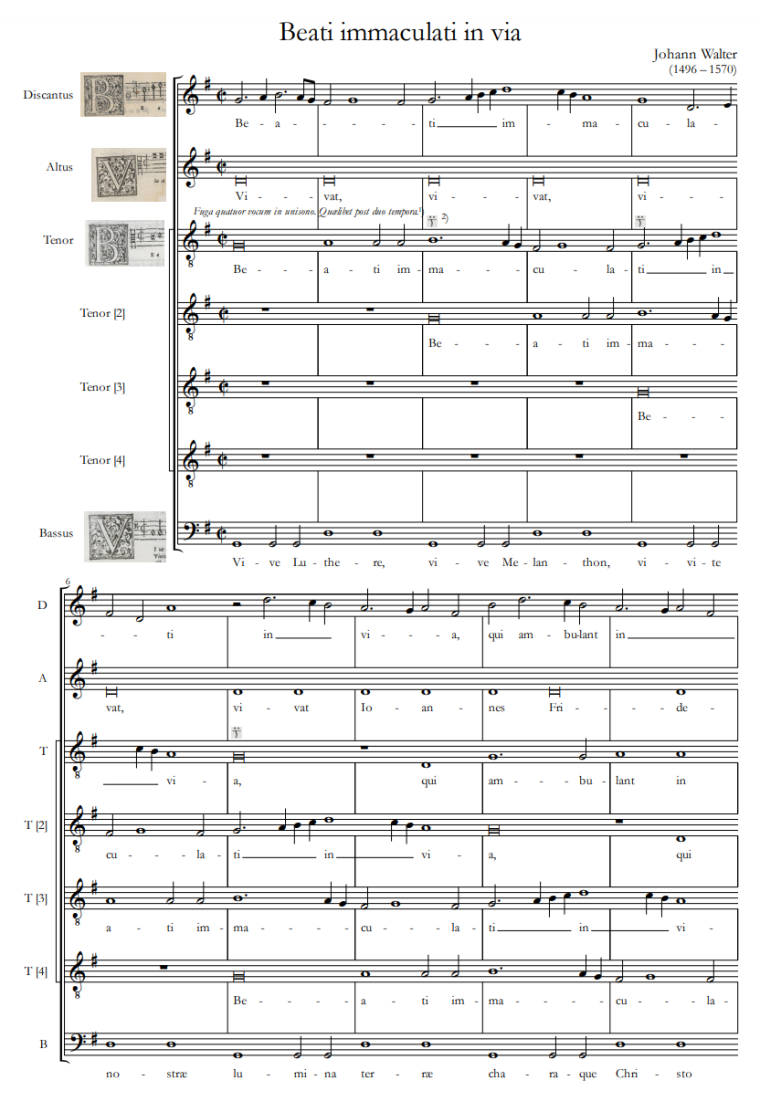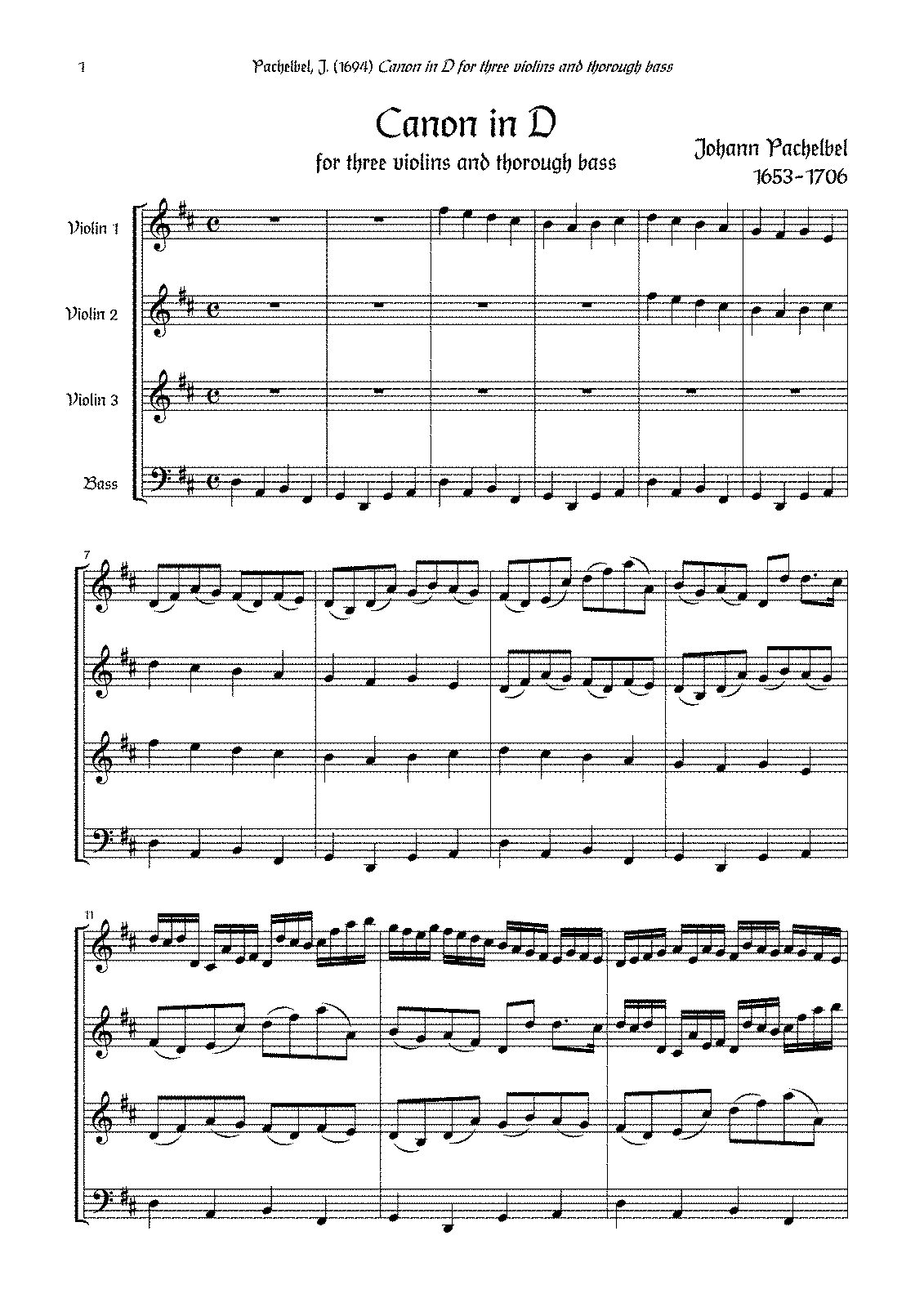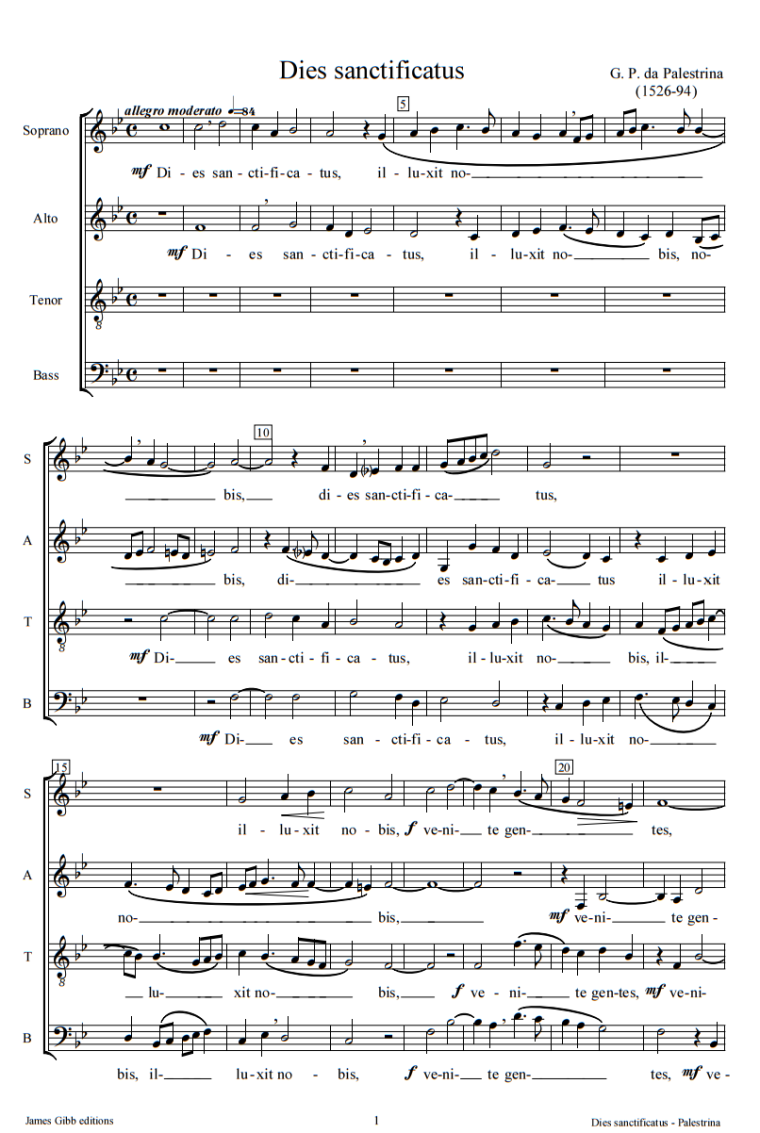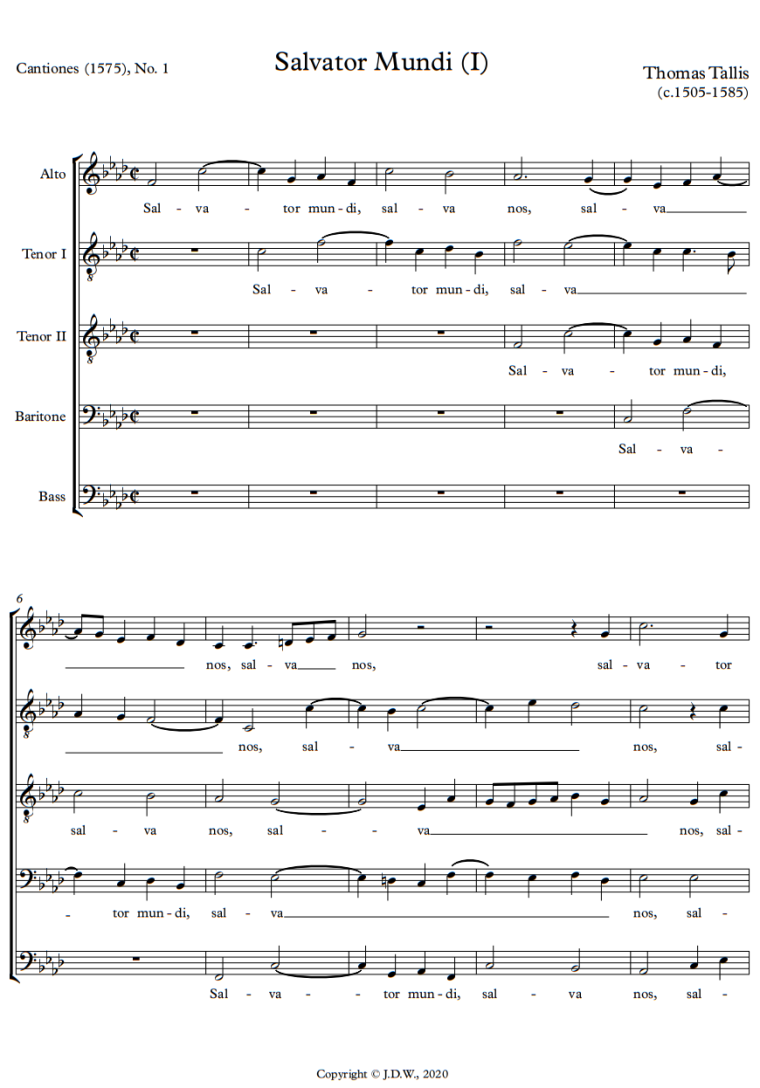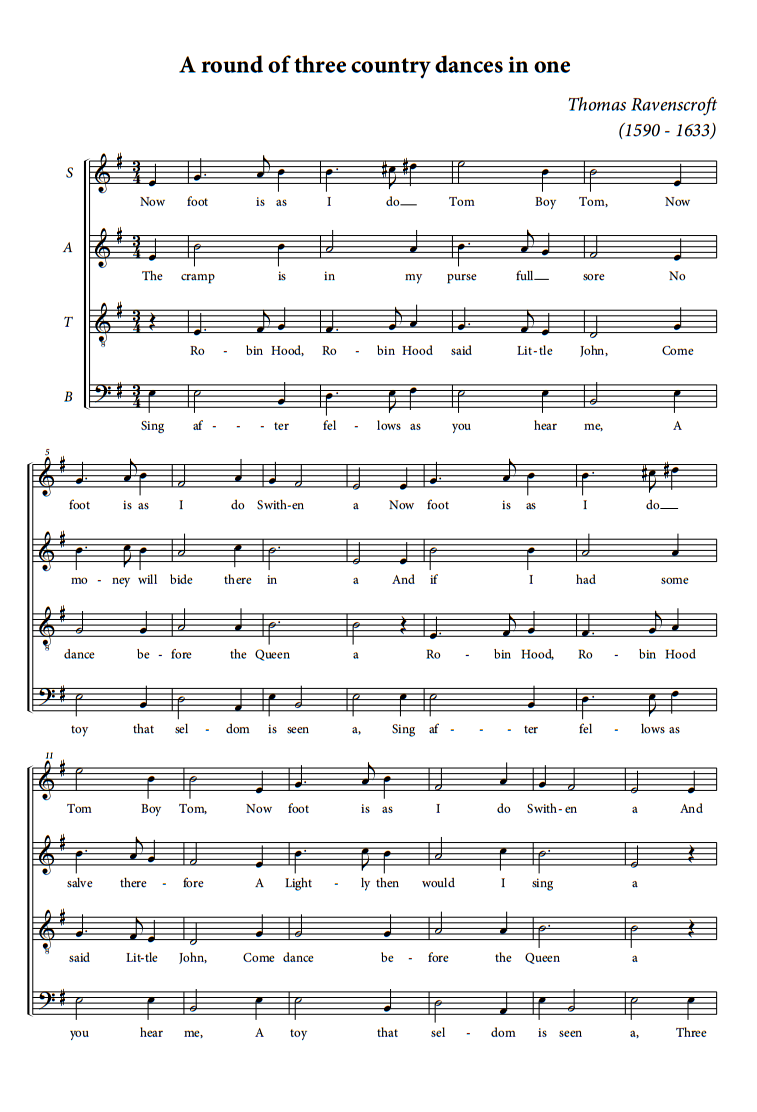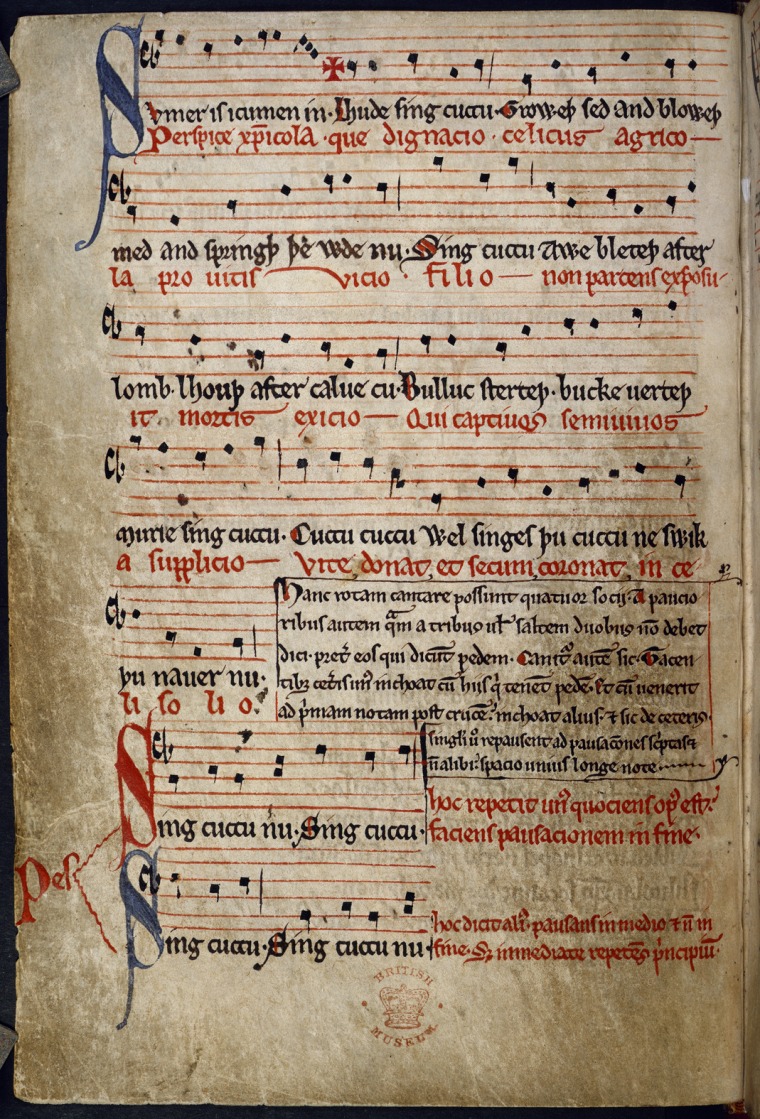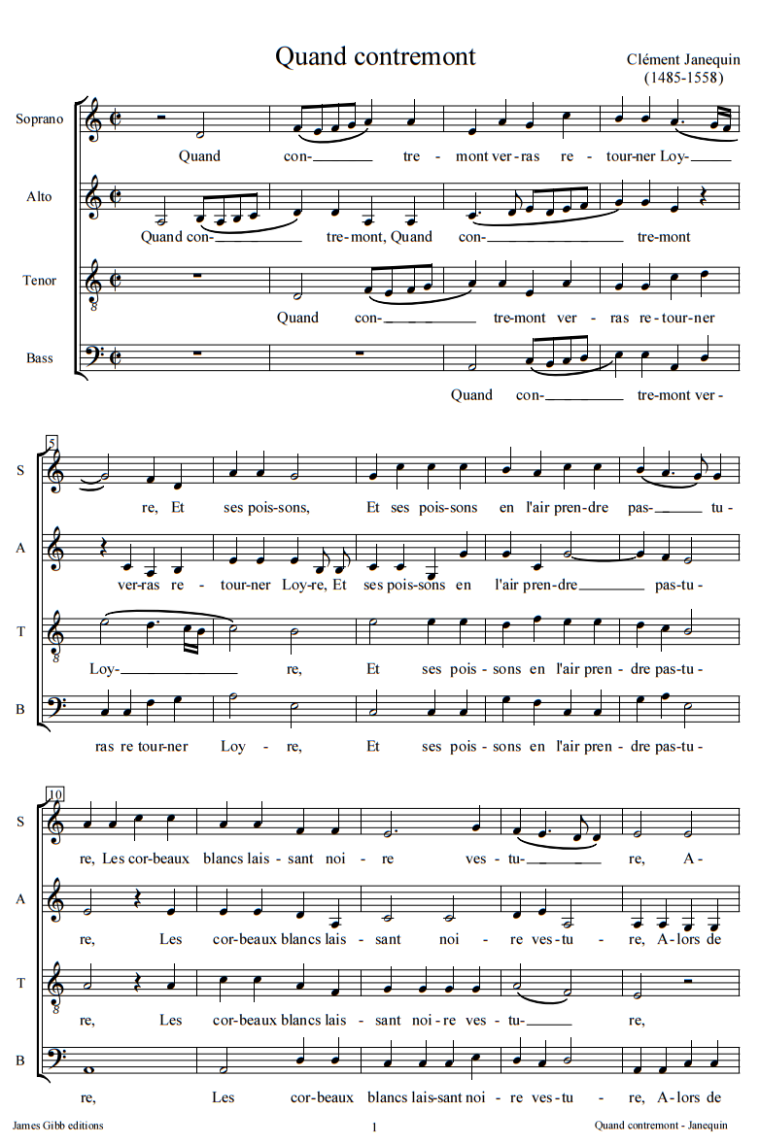Canon alla ottava di J. S. Bach (da Die Kunst der Fuge BWV 1080).
Canon alla duodecima, sempre da BWV 1080.
Canone cancrizzante (dal Musicalisches Opfer BWV 1079) scritto sopra un nastro di Möbius.
Canone «a ventaglio» (ancora da BWV 1079). Si tratta di un particolare tipo di canone infinito nel quale ogni ripresa del tema avviene in una tonalità diversa; generalmente le riprese si susseguono a intervallo di un tono l’una dall’altra (come in questo caso), ragion per cui il canone a ventaglio è anche chiamato, con locuzione latina, canon per tonos.
Quattordici canoni composti da Bach sul basso delle Variazioni Goldberg in un video didattico-divulgativo molto interessante (attenzione, v’è una lunga coda “vuota”: il video ha termine in realtà a 14:45).
Fra i commenti degli utenti di YouTube mi è piaciuto molto quello a firma di SeanPi314: «Se ne evince che Bach non era umano» 🙂







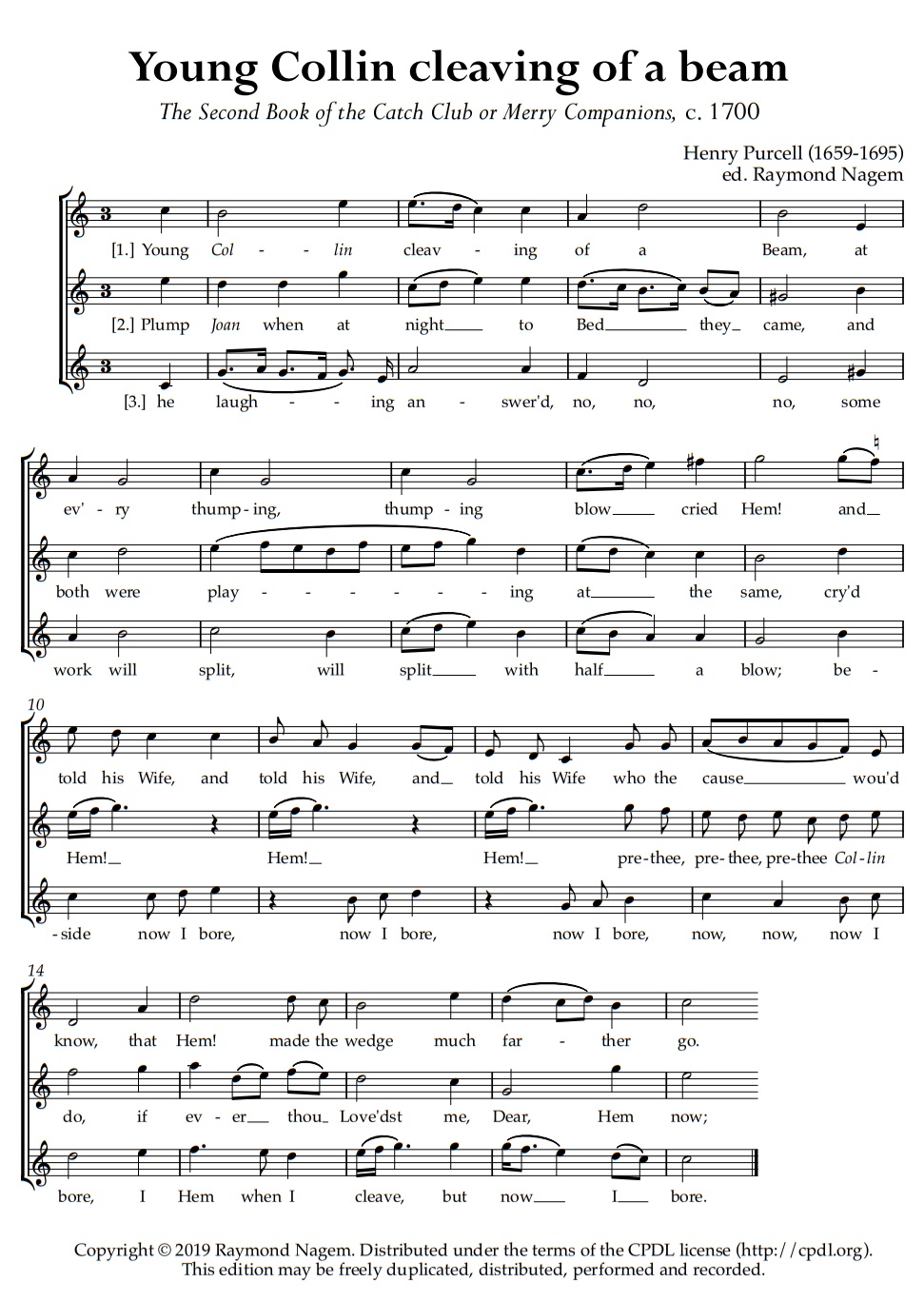
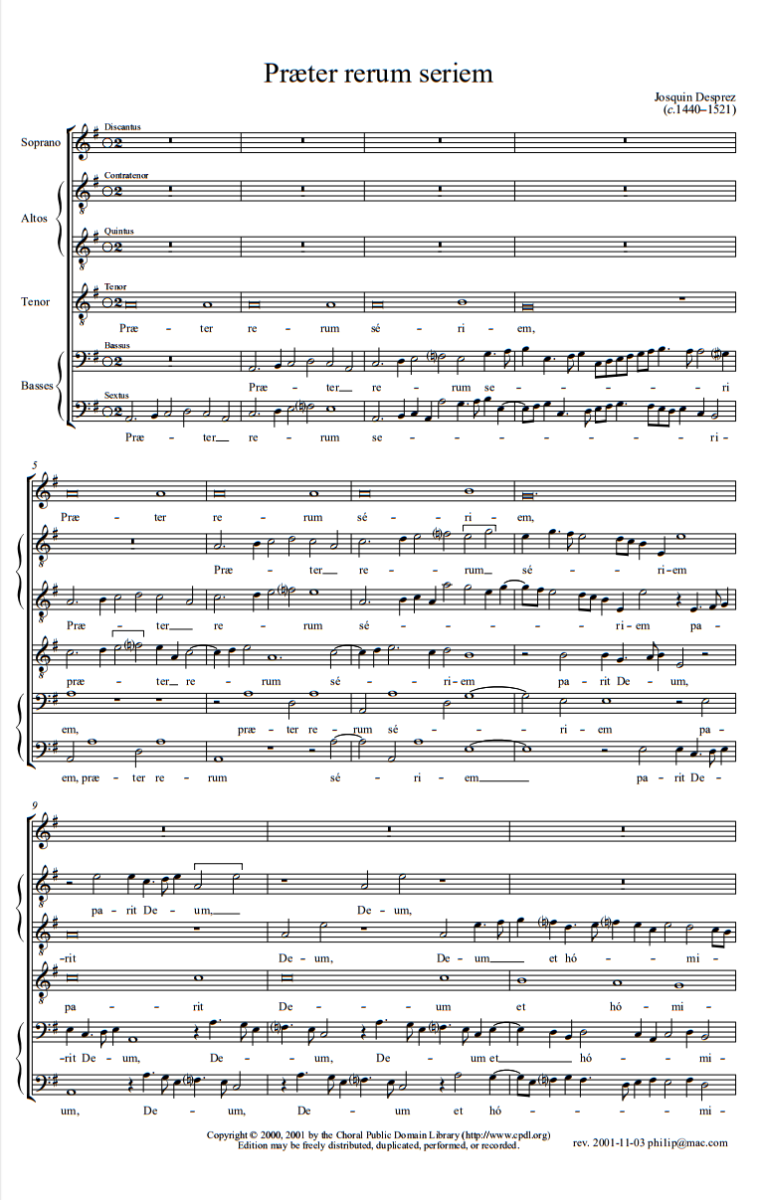

 WAM
WAM